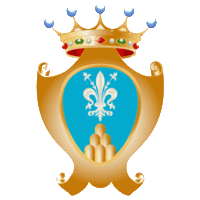Antichi mestieri: il Carbonaio
Fra i tanti mestieri in estinzione o già scomparsi che gli uomini di Montemignaio hanno esercitato fino a qualche decennio fa, quello del carbonaio è certamente il più importante. E Carlo Cassola rammenta proprio i “carbonai di Montemignaio” nel suo libro Il taglio del bosco.
I carbonai erano uomini di montagna che erano costretti a lavorare nei boschi, “macchie” nel gergo, di tutta Italia per guadagnare quel tanto che permettesse un’esistenza “decente” alla famiglia che rimaneva a casa. La permanenza nei boschi aveva una durata annua di oltre otto mesi all’anno, durante i quali i carbonai abitavano in una capanna, da loro stessi costruita con legna e terra. Il mestiere vero e proprio di carbonaio ebbe inizio alla fine del 1700. I pionieri dovettero superare molte difficoltà, sia ambientali che tecniche.
I figli, che allora erano molti e che costituivano la sola ricchezza, avevano bisogno di tante cose a cominciare dalle scarpe, anche se dalla primavera all’autunno usavano i calli sotto i piedi, come il Valentino del Pascoli.
Si ha notizia che a cavallo tra la fine del 1800 e i primi del ‘900 la paga era di 24 soldi (una lira e venti centesimi) per due sacchi di carbone prodotto, di 75 chili ciascuno, o di 120 lire al mese. Il “meo”, ragazzo garzone del quale diremo più avanti, riceveva 15 lire al mese e raggiunse le 40 lire verso il 1915.
Il vitto dei carbonai fu sempre a base di polenta di granturco con un po’ di cacio per companatico; la carne veniva mangiata per Natale e per Pasqua e il vino era privilegio di pochi. Il pane entrò a far parte della loro alimentazione dopo il 1920. I pasti principali erano due: il primo verso le dieci del mattino e l’altro al rientro nella capanna, quando era già calato il buio. La colazione nella capanna consisteva in un po’ di caffè d’orzo e la merenda, limitata al periodo che andava dal 25 marzo alla fine della “stagione” di lavoro, era un tozzetto di pane o di polenta con un po’ di cacio. E pensare che la giornata lavorativa durava circa quattordici ore, senza contare quelle straordinarie per le ispezioni notturne alle carbonaie e per la scarbonatura che cominciava due o tre ore prima dell’alba.
Gli arnesi da lavoro non sono mai cambiati: rastrelli di legno, vagli per l’insaccatura del carbone, pale e zappe di ferro, accette, pennati e roncole, forgiati dai fabbri di Montemignaio, scale di legno, eccetera, e gli indumenti consistevano in: due paia di pantaloni di fustagno o pilorre, un corpetto, due camicie di stoffa nera resistente, un cappello a tesa larga e un colbacco, detto “topa”, due paia di scarpe, dette “tronchi”, e due paia di zoccoli per la scarbonatura, una “fusciacca” (lunga striscia di stoffa nera che veniva girata più volte intorno alla vita per reggere i pantaloni e per proteggere la schiena da strappi muscolari durante i lavori più pesanti). Per il letto, la “rapazzola”, che consisteva in un sacco imbottito di foglie, erano sufficienti due sole coperte anche durante l’inverno perché in mezzo alla capanna ardeva, giorno e notte, il fuoco, che serviva per cuocere i cibi e per far lume. Gli utensili per la cucina si limitavano a: un paiolo di rame, che serviva per cuocere la polenta ed era l’unico piatto di portata, un grande tegame per cuocere un po’ di pancetta di maiale, qualche tazza e alcune posate di rame.
Ogni “compagnia”, gruppo di carbonai, aveva un garzone, il “meo”, che era quasi sempre un ragazzo di circa dodici anni, che svolgeva vari lavori anche troppo gravosi per la sua età: cucinava la polenta, andava ad attingere acqua a sorgenti distanti a volte più di un chilometro dalla capanna con un barile di legno che, pieno, pesava oltre trenta chili, tagliava la legna a pezzetti (“mozzi”) per rimboccare le carbonaie, ispezionava le carbonaie anche di notte. E i carbonai adulti lo rimproveravano e, non di rado, gli davano qualche “manata”, spesso senza motivo. Va detto, per la verità, che tutti i carbonai avevano fatto il “meo” e che quindi avevano patito quei duri trattamenti.
Antichi mestieri: il Vetturino
Il termine “vetturino” significa quello che il vocabolario recita per il “vetturale” e cioè “chi guida cavalli o muli per trasportare merci o persone”. Va detto però che il lavoro del vetturino non si limita alla guida delle “bestie” ma riguarda anche il carico e lo scarico delle “some” e tante altre cose. Il mestiere del vetturino risale quasi sicuramente ad epoche antichissime, forse a quando l’uomo riuscì ad addomesticare il cavallo e simili.
Il vetturino trasporta, con i suoi muli e cavalli, legna, carbone, e altro materiale legnoso, dai boschi dove non ci sono strade carrozzabili, fino alle “piazze” dove vengono erette le carbonaie o ai vari punti di raccolta ai margini dei boschi stessi. Il vetturino non abita in una capanna come il carbonaio, ma in case coloniche, nelle vicinanze dei boschi, dove c’è la possibilità di avere una stalla per le sue bestie. Dorme in un vero letto e mangia a tavola apparecchiata i cibi cucinati dalla massaia del podere. Tutto a pagamento, s’intende. La giornata lavorativa del vetturino, che inizia a giorno fatto quando le bestie hanno mangiato e bevuto, non termina dopo il rientro serale, ma si protrae, seppure in maniera non continuativa, fino a tarda ora per far mangiare le bestie, per farle bere, per riempire di fieno le mangiatoie e per attaccare al collo di ogni mulo e cavallo la “musiera” riempita per metà di biada. Il vetturino “professionista” è capace di diagnosticare le malattie più comuni delle sue bestie, di curarle con medicine preparate in gran parte da lui stesso, e di sanare le ferite. Se la bestia è malata o infortunata, il vetturino segue assiduamente il decorso della malattia o infortunio, alzandosi dal letto anche di notte. Se nelle vicinanze del bosco non c’è un maniscalco provvede da solo alla ferratura. Il vetturino ha un rapporto quasi amichevole e di rispetto con le sue bestie, anche perché costituiscono il suo capitale. Durante le varie fasi del lavoro c’è un vero e proprio dialogo tra uomo e animale, dialogo che permette la parola solo all’uomo ma che trova risposta con sguardi “affettuosi” o meno, con obbedienza, e anche con ribellione, spesso motivata, a ordini non graditi. Ogni bestia ha un nome proprio, alcuni sono quelli di “battesimo” mentre altri sono inventati dal vetturino e si riferiscono al colore del mantello, al fisico, alla provenienza geografica, al carattere, ecc. I più comuni sono: Moro-a, Romano-a, Pallino, Pippo, Fulino, Magnana, Pastora, Topo, Serpente. Le bestie vengono classificate in modi: è detta “agevole” la bestia che non dà segni di irrequitezza, “ombrosa” quella che manifesta la paura con calci e scossoni a causa di rumori improvvisi, “sitosa” è detta la bestia che si “rivolta” contro gli estranei, mentre si dimostra agevole con l’amico vetturino che riconosce al “sito” (odore). Viene definita “pallesca” la bestia che muta spesso di umore, come noi quando ci rompono le … scatole.
Il vetturino ha fama di “imprecatore”, tanto per usare un eufemismo, ma non se la piglia mai con Sant’Antonio, protettore degli animali. Al massimo lo definisce “accio” e mai con rabbia. Nel giorno dedicato al Santo, lui e le sue “bestie osservano completo riposo, con in più un pranzo speciale per lui e doppia razione di biada per loro. I vetturini sono esperti intenditori di vino, “capaci” bevitori e accaniti giocatori di “morra”.
Una nota di carattere militare. Fino agli anni Sessanta, muli e cavalli venivano precettati, ossia erano a disposizione dell’esercito per eventuali necessità. In caso di chiamata alle “armi”, lo Stato pagava al proprietario il giusto prezzo.
Il mestiere di vetturino, che è quasi scomparso, viene praticato oggi quasi esclusivamente per il trasporto di materiale legnoso dai rari boschi non raggiungibili per mezzo di strade camionabili.
Antichi mestieri: il “Meo”
Quando abbiamo descritto il mestiere di carbonaio, mestiere che solo qualche appassionato tiene ancora in vita, abbiamo detto che ogni “compagnia” di carbonai, composta da quattro o cinque uomini, aveva un garzone di circa dodici anni. Era il “Meo”. Il nome “Meo” pare si rifaccia al “miao” di qualche gatto montanino, come recita la lunga “canzone del meo”, scritta in ottava rima da un carbonaio pistoiese, che veniva cantata nelle capanne quando il cattivo tempo “costringeva” al riposo i carbonai.
Il “reclutamento” del Meo avveniva poco tempo prima della partenza dei carbonai, in novembre o dicembre. Il capo compagnia, o altro componente del gruppo, parlava col babbo del ragazzo, e a volte, con la mamma, per stabilire il compenso. Va subito precisato che tutti i carbonai erano stati “mei” e che, quindi, conoscevano bene i sacrifici cui andavano incontro i ragazzi.
Le ragioni della “cessione” temporanea di un figlio erano principalmente due: la prima era quella di togliere da casa una bocca da sfamare, con il vantaggio di ricavare qualche centinaio di lire, e la seconda riguardava l’apprendimento del duro mestiere da “maestri” non condizionati da legami affettivi. Alcuni carbonai, infatti, conducevano alla “macchia” un loro figlio, destinato sì a svolgere le mansioni di meo , ma con un trattamento da padri e non da padroni. E la cosa è ben diversa.
Si diceva che il meo veniva “contrattato”. Il padre, carbonaio anche lui, ascoltava le offerte e ne discuteva, mettendo in risalto il trattamento umano. Le promesse non sempre venivano mantenute, tranne quella relativa al compenso in denaro. La vita alla macchia faceva dimenticare che fuori dal bosco esiste un mondo dove ognuno è persona.
Fissati il compenso e la data della partenza, cominciavano le pene per la mamma del ragazzo, la quale poteva solo piangere in silenzio e preparare al figlio le poche cose necessarie. Si preoccupava di mettere nel “fagotto” (sacco di tela) camiciole e calze di lana, da lei stessa confezionate, contro i rigori dell’inverno. Non dimenticava mai di cucire una medaglietta della Madonna all’interno delle camiciole, come protezione da malattie e infortuni.
Il “meo” di prima nomina partiva contento per l’avventura. Lasciava la montagna desideroso di conoscere luoghi lontani e gente diversa da quella di tutti i giorni ed era felice di viaggiare in treno, che vedeva per la prima volta. Si sentiva importante e compativa i compagni rimasti a casa, costretti ad andare a scuola tutte le mattine e a portare le pecore al pascolo ogni pomeriggio, magari con il libro per studiare. I primi giorni alla macchia costituivano per il meo un fatto straordinario. Aiutava con entusiasmo i carbonai a costruire la capanna e in qualche altro lavoro leggero. Ben presto, però, l’impatto con la realtà gli faceva rimpiangere amaramente la vita povera ma serena del paese. Avrebbe preferito andare a scuola dalla mattina alla sera e badare al gregge durante la notte. Il meo era il cuoco della compagnia. Non c’erano pietanze speciali da preparare, però cucinare la polenta non era cosa facile. Ogni giorno erano rimproveri e maltrattamenti perché la polenta era troppo salata o troppo sciocca, poco cotta o piena di “torzoli”, e così via. La cucina era niente in confronto alle altre occupazioni: c’era da metter fuoco alle carbonaie, da preparare i “mozzi”, da ispezionare le carbonaie anche durante la notte. Il meo andava ad attingere l’acqua a sorgenti distanti dalla capanna anche qualche chilometro, con un barile di legno che al ritorno pesava quasi trenta chili: una “soma” troppo pesante per spalle ancora gracili. Al rientro nella capanna erano sempre rimproveri: “c’è da raccattare la foglia”, “da rimboccare le carbonaie”, “da fare i mozzi”, e tu perdi tempo a riposarti.
Fortunatamente il lavoro alla macchia è finito. I vecchi carbonai sono da tempo in pensione e i figli sistemati in città. I nipoti non sanno nemmeno chi era il “meo”.
Mi piace ricordare questa umanissima figura di ragazzo, forzato eroe, con l’ultima strofa della canzone a lui dedicata:
“L’aria è chiara, tiepida e leggera/ la campagna di fiori e d’erbe è ornata/ canta quell’usignol con buon maniera/ la canzone del meo addolorata./ Inneggia e canta la natura intera/ inneggia alla campagna terminata./ Io d’arrivare in fondo non credéo/ Dio mi riguardi di rifarlo il MEO.”
Tradizione e consuetudini: L’Allegra Brigata De “I Vecchioni”
Fino agli anni cinquanta Montemignaio era molto popolato. Per una vita decorosa delle famiglie, allora ricche di figli, occorreva lavorare sodo. La terra da coltivare era poca e i suoi frutti non bastavano per tutti. Nel paese mancava qualsiasi attività industriale, e quella artigianale si riduceva a tre o quattro falegnami, un decina fra calzolai e ciabattini, due fabbri e tre mugnai. E allora gli uomini erano costretti ad andare alla “macchia” a tagliar legna e a far carbone, abbandonando casa e affetti per otto o nove mesi all’anno, in varie regioni d’Italia. E che c’entrano i “vecchioni”, mi si potrebbe chiedere. Ecco la risposta: è quasi certo che i vecchioni sono “nati” proprio per dare un allegro e festoso saluto a quanti rimanevano a casa. Ed ecco un’altra domanda: chi erano i “vecchioni”? Erano giovanotti mascherati che desideravano divertirsi e divertire per non pensare, almeno per un giorno, al lavoro quasi inumano che li attendeva.
La gente del paese accoglieva con gioia l’allegra brigata nel suo girovagare di frazione in frazione nella vigilia dell’Epifania. Si diceva che i vecchioni erano di buon auspicio per l’anno da poco iniziato e la gente si preoccupava quando mancavano all’appuntamento annuale. Lo testimonia il detto “triste quell’anno che i vecchioni non vanno”. Purtroppo sono già diversi anni che non sono “andati”: speriamo che l’anno 2004 segni il ritorno di questa bella tradizione, anche se, e per fortuna, il lavoro del carbonaio è ridotto a qualche “inguaribile” nostalgico, magari un giovane che non vuole far morire il mestiere che ha sfamato tante famiglie in tempi difficili per tutti. Ma torniamo all’argomento. La tradizione vuole che i personaggi dei vecchioni fossero di sesso maschile. E si può capire perché a quei tempi le famiglie patriarcali non permettevano alle donne di partecipare a manifestazioni pubbliche con uomini. Durante le ultime uscite i vecchioni hanno accolto nel gruppo anche le donne, soprattutto giovani e belle. I pareri su questo cambiamento sono discordi. Le scene principali che si rappresentano nel girovagare nelle varie frazioni del paese vengono ancora interpretate da uomini.
Il personaggio principale delle sceneggiate è il “giudice” il quale ha il potere indiscusso di “condannare” chicchessia, con tanto di sentenza in versi satirici, a dare offerte.
Nei tempi andati le offerte erano generalmente in natura: fagioli, patate, castagne, uova, granturco, frutta, ecc. mentre nelle ultime uscite la gente ha offerto denaro. Durante le varie soste per le sceneggiate, le famiglie del posto offrono cibo e bevande, vino rosso per gli uomini e vin dolce o vinsanto per le donne a tutta la numerosa compagnia. Vediamo gli altri personaggi: la “signorina”, il “cancelliere”, che porta sulla schiena il grosso libro delle sentenze che vengono lette dal giudice, la “vecchia”, vestita da Befana, il “neonato”, “frati”, “preti”, “carabinieri”, eccetera.
La giornata dei vecchioni inizia di buon’ora con il raduno per la truccatura e per indossare i costumi. In questa fase c’è sempre un po’ di confusione e qualche rimprovero, ma la voglia di cominciare la bella avventura al suono di una fisarmonica mette tutto a posto. Appena pronti, i vecchioni partono e vanno, per strade e sentieri, in tutte le frazioni accompagnati da festosi applausi e strilli gioiosi di un folto stuolo di ragazzi al seguito. E così per tutto il giorno, anche quando è calato il buio. Durante il girovagare, nelle piazze e nelle piazzette si dà spettacolo: il neonato strilla e il dottore gli cava un dente, la vecchia ha le doglie e si butta per terra spasimando fino a quando la levatrice non le ha tolto dalla pancia un paffuto bambino. Le sceneggiate sono diverse durante la giornata per cui tutti i paesani, soprattutto i bambini, hanno modo di divertirsi.
Non resta che lanciare un appello ai giovani di buona volontà e con tanta voglia di divertirsi affinché riportino, per le strade, le vie e le piazze di Montemignaio, i “vecchioni” e con loro la sana allegria.
Tradizione e consuetudini: la Digenda
A Montemignaio non c’è nemmeno una pecora. Non è una battuta. E’ la realtà d’oggi. La stessa cosa si può dire per i muli, i cavalli, i “somari”. Non si vede nemmeno un “ocio”, il grosso palmipede che bastava da solo, cucinato in vari modi, per il pranzo della “battitura” del grano. In questo articolo ci occuperemo delle pecore, mansueti, ma non troppo, animali che fornivano ad ogni famiglia del paese latte e derivati, carne, lana, e un po’ di soldi che si ricavavano dalla vendita di qualche agnello.
Prima della forzata “migrazione” in città degli anni sessanta di gran parte della popolazione, tutte le famiglie che possedevano un po’ di terra avevano qualche pecora. Per condurre al pascolo le piccole greggi occorreva una persona per l’intera giornata. Il compito poteva essere affidato a bambini in età scolare, ma solo nel pomeriggio perché la mattina andavano a scuola, oppure si doveva “sprecare” una persona adulta che poteva svolgere un lavoro più redditizio, nei campi o alla “macchia” a far carbone. Si ricorreva talvolta ai vecchi, ma non tutti erano “affidabili”. E allora … nel 1894 il problema fu risolto con la “dicenda” (o vicenda?). Si trattava di formare ogni mattina un unico gregge di circa 150 pecore e di affidarlo, a turno, ogni giorno a due pastori. Il “regolamento” non fu mai scritto, perché a quei tempi contavano le parole dei “galantuomini”, come ci ha riferito il novantasettenne Tertulliano, per gli amici Beppino di Camerino. Ecco alcuni punti del regolamento. – Ogni famiglia doveva fornire un pastore per una giornata ogni due pecore possedute. – Le pecore venivano radunate in un luogo convenuto entro un’ora stabilita, secondo le stagioni. – Quando un proprietario di pecore non poteva rispettare il proprio turno, doveva scambiarlo con altri pastori o pagare chi andava per lui. – Non era consentito il pascolo nei campi, quindi le pecore dovevano mangiare nei boschi o nelle selve di castagni. In queste ultime c‘era il divieto di pascolo nel periodo della raccolta delle castagne e allora i vari proprietari affidavano, a pagamento, le pecore a qualche contadino. – Quando una pecora si smarriva, alla ricerca doveva partecipare anche il proprietario. – Se le pecore arrecavano danni in un campo seminato erano i pastori di turno a pagare. – Per le pecore “nuove” per la dicenda e per le agnelle occorreva una particolare attenzione fino a quando si erano abituate alla vita di “gruppo”. – Al rientro serale le pecore dovevano essere “satolle”. Se veniva accertato che avevano ancora fame, i pastori venivano aspramente rimproverati e diffidati. – Le capre non potevano prendere parte alla dicenda perché arrecavano danni mangiando i germogli delle piante dei boschi. – Se una pecora figliava durante la dicenda, i pastori dovevano tenere in braccio l’agnellino fino al rientro in paese. In compenso ricevevano una coppia di uova dal proprietario della pecora. – Durante l’estate le pecore smettono di mangiare nelle ore più calde e si fermano tenendo il muso rivolto verso terra. Questo intervallo, detto “meriggio”, serviva ai pastori, specialmente a quelli giovani, per dormire, per giocare, per mangiare in santa pace qualche fetta di polenta di castagne o un tozzo di pane con mezza salsiccia o con un pezzetto di aringa.
Al rientro in paese le pecore, che la mattina arano state accompagnate al luogo di raduno dai proprietari, tornavano da sole nelle stalle dislocate nelle varie borgate. Era uno “spettacolo” che meravigliava e divertiva i villeggianti che soggiornavano a Montemignaio durante l’estate.
L’uomo e le castagne
Chi si inoltra, oggi, per i boschi, avverte subito un grande disagio per la impraticabilità di buona parte dei sentieri, a causa delle ginestre, delle scope, dei rovi che sono cresciuti liberamente da quando l’uomo fu costretto, negli anni cinquanta, ad emigrare nelle città per un lavoro che gli consentisse una vita migliore. Quello stesso uomo che spesso si è “sfamato” con il dolce e nutriente frutto, raccolto con tanti sacrifici. L’abbandono delle selve si è verificato soprattutto nei paesi di montagna, specialmente dove è quasi assente la coltura del “marrone”, castagna pregiata che viene venduta a buoni prezzi. Quali, allora, le conseguenze? Prima fra tutte la non raccolta delle castagne, dovuta alla invasione del terreno di un fitto sottobosco che fa “sparire” i frutti. Ci sono poi da lamentare le malattie e la morte precoce di tantissime piante di castagno, per mancanza di “cure”. Non tutte le selve del Casentino sono, però, abbandonate. Nelle zone di Cetica, di Garliano, nel Comune di Castel San Niccolò, diversi anziani attaccati alla loro terra, provvedono alla cura delle piante e alla raccolta, seppure parziale, dei frutti. E la stessa cosa si può dire per Ortignano-Raggiolo e Castel Focognano. “Finché si dura noi vecchi – sospirano in molti – qualcosa si raccatta, ma poi andrà a finire che gli spini arriveranno anche alle porte delle nostre case”. E’ una amara prospettiva che ci auguriamo non trovi conferma nel futuro. Molte giovani coppie sono andate a vivere nei paesi di campagna e si avverte un ritorno, seppur timido, ai campi e ai boschi. E’ già un segnale di speranza.
Dopo questo preambolo, affrontiamo in breve l’argomento con l’intento di ricordare ai “vecchi” e di far conoscere ai giovani il rapporto che esisteva tra l’uomo e le castagne.
Ecco alcuni proverbi e qualche rima dei tempi andati: – Quando piove di giugno si seccan le castagne senza “fummo” (fumo) – Per San Michele (29 settembre) la succiola (castagna lessa) nel paniere – Per San Simone e Giuda casca l’acerba e la matura – Nel tempo delle castagne il porco ride e la pecora piange – Benedetta la castagna / e quel frutto che la mena / siam satolli io e la cagna / e la pentola è sempre piena.
A Montemignaio c’era una tradizione: Castagne per le anime del Purgatorio. Ogni proprietario di castagneti donava al parroco del paese una quantità di frutti in proporzione alla vastità delle selve possedute. Al termine della consegna delle castagne veniva bandita un’asta, alla quale partecipavano vari commercianti del Casentino. Il denaro ricavato veniva impiegato per la celebrazione di S. Messe in suffragio delle anime del Purgatorio.
Le castagne si possono “cucinare” in diversi modi. Con il frutto fresco e integro si fanno i “baloci” (castagne lesse) e le “brici” (bruciate o caldarroste). Con il frutto fresco e sbucciato si preparano le “tigliate” (marroni lessati in acqua salata con il finocchio selvatico secco). Con la farina di castagne si fanno: la “pulenda” (polenta), il “bardino” (castagnaccio), le frittelle. Le castagne secche si possono mangiare crude o lessate. La buccia tritata delle castagne, “zanza” (sansa), viene usata per coprire il fuoco per far bruciare la legna più lentamente senza diminuirne il potere calorico.
Vediamo ora i vari lavori che si eseguono prima, durante e dopo la raccolta delle castagne fino alla trasformazione in farina.
La prima operazione è la “rimunitura”, cioè la ripulitura del terreno, che ha inizio nel mese di settembre e che si protrae fino alla caduta delle castagne “primaticce”.
A questo lavoro si dedicano soprattutto gli uomini. Per mezzo di falci e pennati si tagliano ginestre, felci, scope, spini ecc., cresciuti dopo la raccolta dell’anno precedente. Con la zappa, si fanno, o si rifanno, le fossette nei punti di maggior pendenza del terreno per impedire ai frutti di “scivolare” nei castagneti confinanti. Il materiale tagliato viene accumulato in vari punti e poi bruciato.
Ogni quattro o cinque anni, da aprile a maggio, i castagni vengono puliti, cioè privati dei rami secchi e di quelli che non danno più frutti.
Veniamo alla raccolta delle castagne. Gli arnesi necessari sono: un paniere, fatto con stecche di castagno, una forcina di legno, alcuni sacchi di tela, la “pannuccia” (grembiule di tela), la “patanorcia” (sacchetto di ruvida stoffa che viene legato ai fianchi), la “viglia” (specie di scopa fatta con frasche di castagno).
Il vitto si limitava, fino a diversi anni addietro, a qualche fetta di polenta o di pane con un po’ di formaggio o di rigatino o salsiccia. Le bevande erano l’acqua o l’”acquarello”, ricavato dalla spremitura della vinaccia con aggiunta di acqua.
Durante la raccolta delle castagne, la giornata lavorativa andava da “buio” a “buio”, cioè si partiva prima dell’alba e si tornava a casa dopo il tramonto.
Giunti nel bosco, il gruppo dei raccoglitori, formato da uomini, donne e bambini, riempiva i panieri di castagne e ne travasava il contenuto, di volta in volta, nei sacchi di tela sistemati, qua e là, a ridosso delle piante. E così per lunghe ore. Non c’erano soste nemmeno per consumare i pasti: una fetta di pane o di polenta, con un po’ di companatico, una sorsata di acquarello, direttamente dalla “fiasca”, e … via. Il freddo e l’umidità non consentivano lunghe soste.
Al termine della giornata lavorativa si trasportavano le castagne ai “seccatoi” con l’aiuto di asini o muli; se le selve erano vicine, il trasporto era “umano”.
L’ultima fase della raccolta era la “ricercatura” che consisteva nel cercare le castagne rimaste sotto lo spesso strato delle foglie. Dopo la ricercatura c’era la “busca”: chiunque poteva andare liberamente in cerca di castagne in tutte le selve. La stessa cosa si fa per le noci dopo la “bacchiatura”. Va detto che in alcuni casi venivano fatte le “ricciaie”, cioè si ammucchiavano i ricci chiusi per poi liberarne le castagne servendosi di scarponi chiodati. Le specie di castagne più comuni che si producono in Casentino sono: marrone (la più pregiata), madistolla, raggiolana o roggiolana, pistolese, tigolese (quest’ultima, nelle zone di Garliano, Cetica, Quota, Raggiolo).
Le prime castagne raccolte erano quelle cadute lungo i sentieri, per non farle pestare e mangiare da muli, cavalli e asini che vi transitavano per trasportare legna e carbone, poi quelle che cadevano sulle strade camionabili e quelle cadute ai confini con le selve di altri proprietari.
Le castagne raccolte venivano portate, come detto, nei “seccatoi”, ubicati per la maggior parte vicino alle abitazioni o in mezzo alle selve di grandi dimensioni. I primi sono ormai quasi tutti scomparsi in seguito alla ristrutturazione delle vecchie case, mentre ne sono rimasti in piedi diversi di quelli nelle selve,anche se non in buono stato. I seccatoi erano costruiti in pietra, a due piani. Il piano terreno, con porta e finestra, ospitava il fuoco, mentre il primo piano conteneva le castagne che vi venivano gettate attraverso una finestrella.
La parte inferiore del seccatoio era divisa da quella superiore per mezzo di tavolette di castagno, le “scandole”, della larghezza di circa dieci centimetri e distanti tra loro un paio di centimetri. Questo spazio permetteva al calore del fuoco sottostante di giungere alle castagne ed era sufficiente per impedirne la caduta. Quando il pianale delle scandole era coperto (“accecato”) da uno spesso strato di castagne, si accendeva il fuoco al piano terreno. La legna era esclusivamente di castagno e si usava per lo più quella grossa, non adatta per il focolare domestico.
Si continuava a buttar castagne fino ad arrivare quasi al livello della finestrella. Il fuoco doveva essere continuamente alimentato per non compromettere la giusta essiccatura. Ogni sera, prima di andare a letto, uno della famiglia copriva il fuoco con la sansa di castagne dell’anno precedente per farlo durare fino al mattino.
Quando le castagne dello strato superiore erano asciutte, cioè non presentavano più tracce di umidità prodotta dal calore e dal fumo, si procedeva alla “rivoltatura”: per mezzo di pale di legno si trasferivano le castagne di sopra verso le scandole e quelle di sotto verso il tetto del seccatoio.
Le castagne erano secche quando “suonavano come campanelle”, tanto in superficie quanto in mezzo e in fondo. Allora si passava alla “pestatura”, cioè si liberavano dal guscio.
In tempi remoti questa operazione veniva effettuata a “trespolo”: le castagne secche venivano messe in una specie di vaso fatto con stecche di castagno e pestate con i piedi calzati da zoccoli chiodati. In seguito venne usata la “sacchetta”: si riempivano di castagne secche piccoli sacchi di tela molto resistente e si battevano ripetutamente e con forza sopra un ceppo di legno. Le castagne venivano poi messe in vassoi, anche questi di legno, e buttate in aria , ad una modesta altezza, per liberarle definitivamente della buccia e della pelle. Attualmente la pestatura viene fatta con un’apposita macchina azionata da un motore a scoppio. Le castagne secche e pulite venivano poste in granai dopo una accurata selezione: si scartavano quelle “bacate” e quelle non perfettamente secche, dette “passotti”.
Prima di portarle al mulino, le castagne venivano messe in un forno tiepido, generalmente quando la massaia aveva levato il pane. La macinatura si effettuava in appositi mulini .con macine di pietra azionate ad acqua. Il mugnaio era compensato con denaro o con la “mulenda”, cioè con una percentuale di farina in proporzione al peso delle castagne macinate.
L’ultima operazione era quella relativa alla conservazione della farina: si pressava in appositi granai, dai quali la massaia ne prelevava un po’ ogni giorno per la “pulenda”.
In Casentino esiste ancora un mulino ad acqua che macina esclusivamente le castagne seccate nei “classici” seccatoi: è il “Molinvecchio” di Pagliericcio dei fratelli Grifoni.
Concludiamo il nostro discorso sulle castagne con una nota positiva: alcuni produttori di Montemignaio e di altri paesi del Casentino hanno cominciato, e pare con successo, a praticare l’innesto di marroni su castagni sani e ne hanno già raccolto i primi frutti.
IL PANE DEI POVERI
Quassù le nebbie
sono veli trasparenti
nei mattini di novembre
quando sciamano
dai silenzi delle case
i raccoglitori di castagne
coi sogni spezzati
e le mani appena intiepidite
da una svelta fiammata di ginestre.
Muto è il cammino
nel baluginare tra i viottoli.
Monotono inizia il lungo giorno
per le scoscese selve
tra fruscii di foglie.
Tante agili incallite mani
colmano sacchi di fatica
che saranno pane
per il nevoso inverno.